Le sette liriche in cui è suddiviso il Carme di Febbraio di Rocco Futia riescono ad esprimere con efficace ricchezza di immagini il profondo accoramento che la morte del giovane Achille Pittari ha suscitato in tutti coloro che lo conoscevano. Il tormento espresso dal poeta in questo componimento non è però un tormento personale. O meglio, non è solo un tormento personale: mettendo quasi in disparte la figura autoriale, celando il più possibile l’io poetico, Rocco Futia universalizza il sentimento del dolore attraverso un peculiare tipo di focalizzazione. Ovviamente, non alludo alla tecnica della prospettiva; mi riferisco piuttosto all’accensione di un ‘riflettore’ puntato sulle persone care (i congiunti, gli amici…) che, sotto il cono di luce, non possono evitare di mostrare in vitro la loro anima.
Si consideri, ad esempio, come il padre dismette il suo ancor prestante vigore per trasformarsi nel “vegliardo” che con la “parola / forse vana / forse no” continua a tessere le lodi di chi non smetterà mai di adorare; o si pensi alla madre che, pur piangendo col “cuore di colomba”, è simile a un “prode guerriero” per il sovrumano coraggio dell’accettazione rassegnata di uno spietato destino.
Lo svolgimento della parabola del carme è sottolineato dai titoli delle sette liriche che lo compongono (“Dopo l’inverno dei mortali”, “Ancora una parola”, “Il coro dei viandanti”, “L’elogio del silenzio”, “La sfida”, “L’alba del ricordo”, “Cose tra le cose”), i quali assolvono a una importante funzione paratestuale. Essi, infatti, permettono l’individuazione dei concetti fondamentali di ogni singolo nucleo, indicando così il percorso tematico dell’intera composizione. Nella prima lirica (e, successivamente, anche nella seconda, che ne è la naturale continuazione, come il titolo “Ancora una parola” indica), viene proletticamente esposta la quotidianità di chi, rimasto in vita, nel tempo si lascerà rapire dal ricordo di quel volto che “tornerà puro / in fondo al cuore”, che si configurerà come “la primavera verdeggiante / dopo l’inverno dei mortali”. E, dunque, già si avvertono le preghiere sommesse della madre; e si preannunciano le riflessioni che, “con occhi unti di brina / e di tramonto”, il padre farà sul calar della sera della propria esistenza, “quando i melograni / ci tolgono l’inganno / prima che la notte / renda effimera la sorte”.
Nel terzo nucleo, “Il coro dei viandanti”, si ritorna, attraverso un recupero analettico, al giorno più buio, a quando, nella grande navata parata a lutto, “stille senza storia / invadono l’ultimo cammino […] ignare / dell’odore dell’incenso / e del profumo delle rose”. Mi pare opportuno sottolineare che in tutto il componimento – che, nonostante il tema tragico, vuole essere soprattutto l’elogio della forza d’animo e del coraggio della sopravvivenza a tanto dolore –, questo terzo nucleo si distacca dagli altri. Infatti, i numerosi lemmi che contengono gruppi consonantici in cui è presente la
<r>, per l’aspra allitterazione suggeriscono la rabbia e l’ira contro l’avversa sorte. Si pensi a come certi sostantivi che si ritrovano sin nei primi versi (“il terrazzo dei sepolcri / nella bruma di febbraio”) ci riportano onomatopeicamente alla tragedia. Più avanti ancora, in questo stesso nucleo, il rotacismo stridente ritorna a far da greve colonna sonora, anche se il significato tenue del messaggio ne sfuma un po’ l’asprezza: “ stille senza storia / invadono l’ultimo cammino / discrete / nel bagliore che circonda i celebranti, / segrete / nel brusio dei cuori, / ignare / dell’odore dell’incenso / e del profumo delle rose”.
Nel quarto nucleo lirico, il titolo “L’elogio del silenzio” ci anticipa l’invito alla rassegnazione ma al contempo anche alla speranza, che non si può spegnere con la morte. Poiché “le parole / a volte sono vane, / fragili”, solo nel raccoglimento si potrà percepire la nuova quotidianità sotto un’altra luce. “Le parole del vespro”, infatti, sono quelle non dette, quelle appena sussurrate; e sono le sole che possono dare “un altro senso alle cose, / nuovi campi al seminatore / […] e l’inattesa immagine del volto”. Il ricordo, perciò, non si sfocherà con il tempo; ma, grazie ad esso, sarà soltanto depurato dalle celebrazioni di maniera. L’immagine dunque, pur se colorata di melanconica nostalgia, senza portare struggimento si delineerà improvvisa, attraverso teneri flashs di una quotidianità passata, attraverso reminiscenze di momenti che erano “un po’ scherno fraterno / un po’ gioco d’affetti / un po’ dolceamaro rimando / a proverbi familiari / e a notti che raccontano / l’amore”.
Ma la difficoltà di superare questa prova del tempo è preannunciata dal titolo del quinto nucleo lirico, “La sfida”. Nella ripartizione del dolore, nella solidarietà, si troverà il modo di sopravvivere all’invernale notte dell’anima, quando la memoria è più propensa a riandare alle mattine di primavera, alle “pianure di sole / con alberi secolari / e valli amene / pigre fino a ieri / e ruscelli gorgheggianti / dopo il disgelo”. “L’esile sfida / [che] avvicina l’uno all’altro” sarà vinta, anche se l’ineluttabile avvenimento, come qualsiasi altra dura prova della vita, avrà lasciato un segno indelebile che cambia l’essere nel profondo. Ancorché nella diversità dei temi, Rocco Futia ci richiama, in questo concetto, alcuni alessandrini del XX poema d’amore di Pablo Neruda: come già avvertiva il poeta cileno, dopo una forte esperienza, pur nell’immutabilità dell’ambiente circostante, siamo uguali al passato soltanto nella nostra veste esterna: “La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. / Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos” [La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi. / Noi, quelli di allora, non siamo più gli stessi]. Come si può notare, la stessa immagine concettuale riecheggia nei versi di Futia: “E pur senza cambiare di un niente / non saremo gli stessi”.
Il titolo del successivo nucleo, “L’alba del ricordo”, ci prepara al tema dell’evocazione: i genitori, unici personaggi contemplati dal poeta in questa sesta lirica, affrontano la tragedia con predisposizione diversa. Mentre la madre è “raccolta nella preghiera / come una sentinella del borgo”, il padre, “in mezzo ai luoghi del paese / e degli amici, / in mezzo ad altri figli vespertini”, continua a rammemorare virtù. La parte più cospicua del nucleo è dedicata proprio al padre, su cui è puntato incessantemente quel ‘riflettore’ di cui si è già parlato. Il “vegliardo” diventa addirittura destinatario diretto del messaggio poetico, per l’insistente figura dell’apostrofe con cui è richiamato: “E tu, vegliardo, / parli di lui”, “Tu, / gagliardo in un anfiteatro di apoteosi”, “Tu, / col nome più amato sulle labbra”, “Tu e la madre”, “Tu, / […] solo / con il tuo urlo segreto, / col volto in cui si placa / l’inganno”.
Infine, “Cose tra le cose”, l’ultimo nucleo lirico, si incammina su un tono più crepuscolare, in cui si possono percepire pacate modulazioni corazziniane. Gli stessi sostantivi del titolo riportano alla memoria l’“Elegia” del giovanissimo poeta romano che, anticipando la propria esperienza di morte, ricordava come gli oggetti ci parleranno per sempre di chi non c’è più: “Tu piangi, ma non sai, piccola cara, / dove, nell’ombra, piangano le morte / cose quel tuo, dolcezza, ultimo addio”. Così, anche Futia. Ma in un modo più diretto e manifesto, vuoi per la limpida sintassi che l’uso del verso libero gli consente, vuoi per la scelta di evitare in queste liriche quella tendenza particolarmente ermetica che lo caratterizza. Gli oggetti menzionati (“riposano libri e occhiali / come cose tra le cose / d’un tempo passato”) sono utilizzati da Futia per sottolineare il contrasto tra ciò che perdura immutato alla tragedia e l’animo umano.
Si sarebbe tentati di credere che in questo ultimo nucleo si ripeta il tema del quinto, vale a dire quello dell’uomo che, pur vivendo immerso in uno spazio inalterato, è stato cambiato dall’esperienza del dolore. Tuttavia tale tema – che sicuramente si ripropone – acquista delle sfumature diverse. Infatti, se da una parte è vero che gli oggetti riposano inermi come nel passato, in una leopardiana ignoranza del dolore, è pur vero, d’altra parte, che a chiusura della lirica Futia introduce alcuni elementi emblematici che, pur potendosi includere nella categoria delle “cose”, acquistano un valore simbolico per la mancanza di staticità che in fondo li caratterizza. Mi riferisco alle tre fontane e alla lanterna. Se quest’ultima, il cui tremolio della fiamma illumina il quadrivio (metafora della pluralità di strade che si possono intraprendere per superare il dolore), tra le altre cose richiama anche il continuo divenire e la consunzione del tempo, ancor più le tre fontane propongono lo scorrere incessante della vita, per l’immagine dell’acqua (cifra contrastante di vita e di morte) e per la dinamicità del suo defluire.
E pare giusto evidenziare che, qui, Futia mette a frutto la sua conoscenza della tradizione lirica spagnola, a cui da anni si è avvicinato con entusiasmo. Si colgono, infatti, rinvii agli scrittori iberici, a partire da Jorge Manrique fino ad Antonio Machado e oltre. Noti sono i versi del primo, che avvertiva come: “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir” [Le nostre vite sono fiumi / che sfociano nel mare, / che è la morte]; così come noti sono, tra i tanti versi in cui Machado propone la stessa figura metaforica, quelli che recitano: “Bajo los arcos del puente pasaba el agua sombría: / (Yo pensaba: ¡el alma mía!)” [Sotto le arcate del ponte passava l’acqua cupa. / (Io pensavo: la mia anima!)].
A chiusura di questa breve presentazione, è doveroso chiarire che, pur avendo qua e là messo in risalto alcuni rimandi letterari di Futia, il suo Carme di Febbraio possiede una decisa originalità. Il poeta, infatti, evita l’ostentazione di citazioni erudite, con il risultato di attenuare gli interventi intertestuali, grazie alla personalissima rielaborazione dei temi e dei simboli utilizzati.
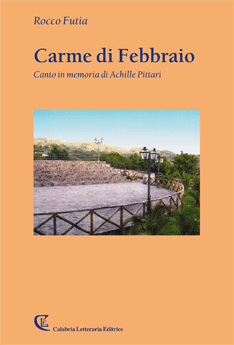 Il poema è stato presentato a San Giovanni di Gerace il 18 maggio 2005.
Il poema è stato presentato a San Giovanni di Gerace il 18 maggio 2005. 